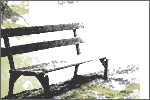
|
Crea anche tu un blog su RockFaMily | HOME
|
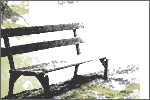
“Cause I Love And I Live Primitive”
The Groupies, 1966
Ho amato da impazzire Garageland. Anche quando il Faulisi e io avevamo come l’impressione che lì fuori, c’era nessuno o quasi ad ascoltare i Detroit Cobras, i Fleshtones o qualche oscura band del Wisconsin scovata in qualche oscura raccolta di oscure band dei più oscuri anni Sessanta che presentavamo con l’entusiasmo di dodicenni infilati di nascosto al loro primo concerto. Mi procurava un brivido mascalzone lungo la spina dorsale la consapevolezza che in quel momento, da nessun altra parte dell’etere radiofonico italiano - e lo dico con buona approsimazione - stava facendo girare incerti vinili dei Long Ryders o della Chocolate Watchband o di qualsiasi altra band senza una hit in classifica. In nessuna classifica. Noi di Garageland ci sentivamo degli Indiana Jones alla ricerca dell’essenza stessa del rock and roll, della sua primitiva follia. Per quasi tre anni abbiamo rovistato nei bidoni dell’immondizia della storia della musica rock, cercando quei suoni ingenui, maleducati, istintivi, senza additivi, senza coloranti né conservanti: lo possiamo chiamare rockabilly, beat, garage punk o forse più semplicemente punk rock (che non è nato coi Sex Pistols, sia ben chiaro!).
Recentemente sono stato invitato a far girare qualche disco - solo vinile, per il Metius! - in un festival divertentissimo dalle parti di Valpolicella. Ho conosciuto un ascoltatore di Garageland: così entusisasta che se non avessi il cuore di pietra lo avrei abbraccciato in lacrime. Mi raccontava che ogni lunedì sera tornava si sintonizzava su quella che una volta era conosciuta come RockFM proprio per ascoltare il Faulisi e il Metius, segnandosi sul telefonetto i titoli e i nomi dei gruppi che più gli piacevano. Il colpo di grazia mi è arrivato quando mi ha confessato di avere comprato un disco perché conteneva la sigla di Garageland, quella che iniziava col countdown...
Anche solo per questo, ne è valsa la pena.
Goodbye Garageland!
Aloha fratelli,
in molti mi avete scritto chiedendomi chi sia in realtà Chuck Bird... Solo un parto di una menta malata - e scissa- o c’è sotto qualcos’altro?
Vi voglio raccontare una storia, se avete il tempo e la voglia di ascoltarla.
La scena si svolge attorno al Ferragosto del 1988, quando il Metius era nel bel mezzo di un viaggio Coast To Coast attraverso quella follia geografica che chiamiamo Stati Uniti d’America. No, cari i miei passerottini e care le mie passerottine, non ero al volante di una Cadillac decappottabile lanciato su di una highway deserta ma col sedere appiccicato al sedile della sala d’attesa della stazione degli autobus di Chicago, Illinois. C’era un sacco di gente, lì attorno, e tutti potevano tranquillamente essere parte importante nel testo di qualche blues... Grandi valigie, scarpe da poco e tutti con la faccia di chi ha solo voglia di andare via.
Stavo scegliendo quale nastro infilare nel walkman quando, accanto a me, prese posto uno strano tipo. Sapete, quel genere di personaggi che è più facile incontrare in un bar intorno all’orario di chiusura che in una stazione della Greyhound: indossava un completo nero, di quelli che potevano essere considerati eleganti almeno un vent’anni prima. Ai piedi aveva un paio di scarpe stupidamente a punta, ma così sfondate che neppure il più grande calzolaio dell’Illinois sarebbe riuscito a rimettere in sesto. La camicia... Beh, poteva essere stata bianca, una volta. Adesso raccontava di notti passate ovunque ma non appesa in un armadio o ripiegata in un cassetto dopo un buon lavaggio. Ovviamente, aveva addosso un paio di vecchi occhiali da sole, clamorosamente rigati. Odorava di pochi bagni, di troppe sigarette e liquori da pochi soldi. Guardò con intetesse le mie cassettine. Sorrise sornione quando ne inquadrò una con l’etichetta “The Who”. Me la indicò con discrezione con un indice che sembrava appena stato intinto nella vernice gialla. Una voce cavernosa, che rivelava nei polmoni una presenza di catrame sufficiente ad asfaltare un lungo tratto della Route 66 bofochiò un: “Uhm... The Who, whatta band. They were crazy, expecially the drummer... That Keith Moon, nut as a squirrel!”. Mancava almeno mezz’ora alla partenza del mio autobus per Saint Louis e non trovai nulla di sbagliato nel dare corda a questa specie di becchino in vena di sparare cazzate su una delle mie band preferite. E lui non si fece pregare: mi raccontò di quando lui era un famoso e starpagato dee jay, “awful rich” secondo lui, e di una notte passata insieme a Keith Moon lavorandosi whiskey di marca e certe pillole colorate che avrebbero fatto correre i cento metri i 9 e 90 a un bradipo in letargo! Ovviamente, non credetti a una sola parola di quanto mi disse. Improvvisamente, il mio nuovo, strano amico si alzò in piedi: dando un’occhiata a un orologio che avrei giurato essere senza vetro né lancette, disse che doveva andare a parlare col boss di una stazione radio importante, la più importante di Chigaco per un nuovo lavoro e che odiava arrivare in ritardo... Gli strinsi quella manaccia ricoperta di nicotina e mi accorsi di non sapere il suo nome. “Mi chiamo Chuck Bird. Quando capiti in città, chiedi di me... Nel giro della musica mi conoscono tutti!”. E così si allontanò ciondolando, senza nessuna fretta.
Tornai a Chicago una decina d’anni più tardi. Quasta volta ero al volante di un’autovettura - ancora nessuna Cadillac, però - e mi venne voglia di cercare con la manopolina una stazione radio rock. Chissà, forse nella remota speranza di ascoltare quel bofonchiare rude, ma elegante, quel cacciare balle con la serietà di chi legge le notizie al telegiornale. Non c’era nessuno che gli somigliasse neppure lontanamente. Voglio credere di avere solo sbagliato orario, che il vecchio Chuck Bird sia finalmente tornato dietro a un microfono, magari di nuovo “awful rich” come ai tempi d’oro.
La radio intanto trasmetteva “Whiskey, Wimmen and Nightlife” di John Lee Hooker ed era comunque un bel viaggiare...